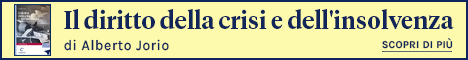
L’elaborato offre un’approfondita analisi del tema della tutela della continuità aziendale. Caratterizza la trattazione una sistematica ricostruzione degli interventi normativi – nazionali e europei – e degli istituti diretti alla tutela della conservazione dell’impresa. In particolare, l’autore, dopo aver individuato i principali interventi sovranazionali a tutela della continuità aziendale, fornisce un’interessante overview della normativa concorsuale di alcuni paesi europei, quali Francia, Belgio, Germania, Spagna e Portogallo. L’autore prosegue con un’analisi degli istituti di “pianificazione della crisi”, messi a disposizione dal nostro diritto della crisi – anche alla luce della nuova disciplina dei sistemi di allerta – e dell’istituto del finanziamento dell’impresa in crisi. La trattazione continua con la descrizione del contributo offerto dal diritto societario e dalla scienza economico-aziendale alla tutela della continuità aziendale e termina con l’individuazione – da parte dell’autore – di un’ipotesi di tutela della continuità aziendale, alla luce dalle caratteristiche intrinseche (e delle principali criticità) delle imprese domestiche.
The essay offers an in-depth analysis of the issue of going-concern protection; it’s characterized by a systematic reconstruction of regulatory interventions – national and European – and of institutions aimed at protecting the conservation of the company. In particular, the author, after identifying the main supranational interventions to protect going-concern, explains an interesting overview of the bankruptcy law of some European countries, such as France, Belgium, Germany, Spain and Portugal. The author continues with an analysis of the “crisis planning” institutes, made available by our crisis law – also in light of the new regulation of alert systems – and the institution of loans to company in crisis. The essay continues with the description of the contribution offered by company law and economic-corporate science to the protection of going-concern and ends with the identification – by the author – of a hypothesis for the protection of business continuity, in light of the intrinsic characteristics (and main problems) of home-based enterprises.
Keywords: going-concern – crisis planning instruments – company’s preservation.
Articoli Correlati: continuità aziendale - strumenti di pianificazione - conservazione impresa
1. Introduzione - 2. L’impulso europeo alla tutela della continuità aziendale - 3. Uno sguardo (fugace) sull’ordinamento concorsuale di taluni paesi europei - 4. Il contributo del diritto della crisi d’impresa alla tutela della continuità aziendale - 5. Il contributo del diritto societario alla tutela della continuità aziendale - 6. Il contributo della scienza economico-aziendale alla tutela della continuità aziendale - 7. Una diversa prospettiva di protezione del going concern - 8. Conclusioni - Bibliografia - NOTE
Il moto perpetuo indica, secondo un’ampia e generale accezione, un avanzamento che non necessita di costante e continuo rifornimento od alimentazione come se proceda incessantemente. Ebbene, in termini metaforici, ci si potrebbe riferire anche alla sequela [si badi al senso fausto del termine] di riforme che hanno investito il diritto della crisi d’impresa a partire dagli anni 2005 e 2006 chiaramente improntate alla tutela della continuità aziendale. Il leitmotiv o il comune denominatore degli interventi riformatori si rinviene, quindi, nella predisposizione di soluzioni normative finalizzate al superamento delle criticità aziendali, la cui meta finale consta nella tutela degli interessi del ceto creditorio. Lo scopo precipuo di questo scritto consiste, pertanto, nel tentativo di dipanare un ragionamento sulla tutela della continuità aziendale e sull’arsenale all’uopo preposto, secondo uno stilema sorvegliato ma non impervio, pur nella consapevolezza del pubblico specialistico cui ci si rivolge. È bene chiarire, sin da principio, che la genesi dell’impulso alla tutela della continuità aziendale si rinviene a livello europeo. Le istituzioni sovranazionali hanno avvertito la cogente esigenza di innestare nel seno degli ordinamenti nazionali principi di prevenzione delle crisi aziendali, anche in considerazione della dimensione internazionale dell’economia. Con riferimento al diritto della crisi d’impresa, è agevole verificare come il tentativo di conservazione dell’organizzazione aziendale si sia estrinsecato tramite l’instillazione di istituti privatistici [il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d, legge fall.] e concorsuali [il concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186-bis legge fall.] o para-concorsuali [gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall., nelle diverse varianti]. Il legislatore, vieppiù, ha ampliato lo spazio perimetrale riconosciuto all’esercizio provvisorio dell’impresa e dell’affitto d’azienda. Gli istituti testé menzionati, en passant, esaltano l’autonomia negoziale delle parti e cagionano al contempo l’arretramento del potere di intervento pubblicistico. Si badi anche alla novellata disciplina del capitale sociale nell’impresa in crisi – che [continua ..]
Lo scopo di questo paragrafo consta nel tentativo di ripercorrere i principali interventi di politica legislativa sovranazionale, il cui filo conduttore si rinviene pacificamente nella conservazione dell’impresa in luogo della sua disgregazione. Secondo una illuminante definizione, è stata «spezzata l’equazione insolvenza-liquidazione […]» [1]. La ratio legis ispiratrice del sovvertimento dei rapporti di forza tra liquidazione e risanamento dovrebbe rintracciarsi nella necessità di tutela del ceto creditorio che la dottrina prevalente individua quale fine precipuo del diritto concorsuale e – secondo una visione a più ampio spettro – del diritto della crisi delle imprese [2]. Il legislatore sovranazionale ha avvertito, pertanto, la cogente esigenza di fornire un impulso sempre più efficace ai singoli stati, affinché questi adeguino i rispettivi ordinamenti in funzione della tutela della continuità aziendale. Il fallimento – capostipite degli istituti giuridici di regolazione della crisi – ha appalesato evidenti limiti nella tutela dell’interesse precipuo del ceto creditorio, che può ricondursi alla massimizzazione dell’utilità derivante dalla disgregazione aziendale. Si consideri, inoltre, l’arco temporale molto ampio lungo il quale si dipana la procedura fallimentare, sicché emerge anche la necessità di considerare la variabilità del valore monetario nel tempo. Inoltre, v’è da aggiungere che la dimensione internazionale dell’economia e l’istituzione del mercato unico europeo, e della moneta unica, hanno impresso un’accelerazione decisiva al processo di armonizzazione della disciplina della crisi d’impresa all’interno dei singoli stati membri dell’Unione europea. Ed ancora, un forte impulso alla riforma della disciplina della crisi d’impresa è rintracciabile anche nelle indicazioni dell’OCSE che ha evidenziato ripetutamente la lentezza ed i rilevanti costi di gestione delle procedure fallimentari [3]. Si evidenziava, inoltre, come la celerità di svolgimento delle procedure di composizione della crisi d’impresa fosse una delle variabili chiave per sviluppare una maggiore forza attrattiva degli investimenti. Infine, il legislatore sovranazionale potrebbe aver intravisto nella forza negoziatrice [continua ..]
Lo scopo del presente capitolo consta in una rapida disamina di taluni ordinamenti europei, onde verificare l’eventuale esistenza di istituti giuridici finalizzati alla tutela della continuità aziendale così come avvenuto nel nostro Paese. In particolare, ci si soffermerà sull’ordinamento francese che notoriamente è caratterizzato dalla presenza di istituti giuridici finalizzati al mantenimento in vita dell’impresa. Si tenterà di scorgere una o più fonti ispiratrici di una politica legislativa – in subordine all’impulso di matrice europea – così chiaramente avversa alla disgregazione dell’impresa in dissesto. Uno sguardo, per così dire, en passant, verrà riservato anche all’ordinamento belga, tedesco, spagnolo e portoghese. Quanto all’ordinamento francese, giova procedere ad una sommaria ed essenziale ricostruzione sistematica e temporale dei principi e più recenti istituti normativi diretti alla tutela della continuità aziendale. il risanamento dell’impresa era la stella polare seguita dalla legge n. 148 del 1° marzo 1984 relativa al règlement amiable, cui seguiva la legge n. 98 del 25 gennaio 1985 che istituiva il redressement judiciaire. Sulla stessa lunghezza d’onda si collocavano la legge di riforma n. 475 del 10 giugno 1994 e l’istituzione del libro sesto del codice di commercio tramite la loi de sauvegarde des entreprises [7]. Il sistema normativo ivi delineato riconosceva amplissimi spazi di autonomia al debitore, tant’è che il legislatore ometteva l’imposizione di termini di durata del piano di superamento della crisi. Ma v’è di più: il Tribunale avrebbe potuto imporre ai creditori, privi di accordi con il debitore, termini di adempimento funzionali al piano di superamento della crisi. L’evidente favor legislativo alla prosecuzione dell’attività aziendale – pur imperversando uno stato conclamato di crisi – era parzialmente attenuato dall’intervento legislativo del 1994. Infatti, si riconosceva un più ampio perimetro d’azione al fallimento che riacquistava piena cittadinanza nell’ordinamento concorsuale francese: le règlement judiciarie poteva intervenire anche senza verificare l’inidoneità del piano di [continua ..]
Il diritto della crisi d’impresa domestico è stato interessato, come è ben noto, da molteplici interventi riformatori favorenti la tutela della continuità aziendale. Le riforme susseguitesi sono state evidentemente accomunate da un tratto, per così dire, parossistico perché intervenute in rapida successione, ma in modo ritmico e sincrono. Nel complesso e composito mosaico normativo si staglia nitidamente il tema della pianificazione della crisi, talché nell’ordinamento irrompono prepotentemente i c.d. piani di gestione e di superamento della crisi d’impresa. Ma si svilupperanno talune osservazioni anche sul tema dell’allerta che costituisce l’altro tratto caratterizzante la novella disciplina della crisi aziendale. Infine, si proporrà un ragionamento sul tema del finanziamento dell’impresa in crisi con talune venature economico-aziendali che si innestano nella trattazione giuridica. La disamina dei profili funzionali vari strumenti pianificatori inizia dall’istituto del piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 67, comma 3, lett. d), legge fall. introdotto con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 e convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Quanto alla novellata disciplina, invece, il dato normativo è contenuto nell’art. 56. L’applicazione dell’istituto in parola si basa sulla presentazione di un piano da parte dal debitore – sovente e auspicabilmente coadiuvato da un advisor – finalizzato al riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa e dell’esposizione debitoria. Il piano attestato di risanamento, pertanto, persegue evidentemente il fine della tutela del c.d. going concern e non dovrebbe prestare il fianco ad ipotesi o prospettive liquidatorie. Ed è proprio nell’ottica di tutela della continuità aziendale che dovrebbe inquadrarsi la valorizzazione, rectius, esaltazione, dell’autonomia privata poiché la disciplina vigente non delinea il contenuto del piano; ancora ne è ampiamente dibattuta la natura di atto negoziale o unilaterale, infatti sul punto vi sono opinioni diverse [11]. La vaghezza del dato normativo è stata colmata dalla novellata disciplina, sicché è lecito chiedersi: il debitore proponente può ancora [continua ..]
La tutela della continuità aziendale avrebbe beneficiato di un contributo rintracciabile – secondo un ragionamento inferenziale – anche nel diritto societario. L’obiettivo del presente paragrafo e di quello successivo è di tracciare una sorta di filo conduttore tra i vari istituti di diritto sostanziale, i cui campi applicativi comprenderebbero anche la prevenzione della crisi d’impresa. Gli strumenti protettivi del going concern avrebbero varcato le c.d. Colonne d’Ercole del diritto della regolazione della crisi aziendale. L’intento perseguito sarebbe riconducibile all’ampliamento del ventaglio di soluzioni finanziarie a disposizione dell’impresa, alla facoltà di sottrazione taluni elementi patrimoniali al generale rischio d’impresa, al potenziamento dei controlli societari e della capacità informativa del bilancio di esercizio. Quanto al primo aspetto, bisogna sviluppare talune riflessioni sugli strumenti finanziari partecipativi la cui (scarna) disciplina è rintracciabile nell’art. 2346, ultimo comma, e nell’art. 2351, ultimo comma. L’istituto in esame presenta profili particolarmente accattivanti, in virtù dell’amplissima autonomia conferita dal legislatore. Infatti, gli strumenti finanziari partecipativi potrebbero essere assimilati ad «un contenitore che potrà essere riempito in base alle specifiche esigenze della società emittente […]» [31]. Gli strumenti finanziari partecipativi potrebbero rappresentare un canale di reperimento di risorse finanziarie nella fase c.d. in bonis dell’impresa, sia in quella costitutiva o di sviluppo [32]. È di tutta evidenza come il reperimento di mezzi monetari tramite gli strumenti finanziari partecipativi – in luogo del ricorso al capitale di credito bancario – comporti un rilevante beneficio per l’autonomia finanziaria dell’impresa e per la continuità aziendale. E qui ci si può ricollegare al tema più ampio dell’attenuazione del canone della proporzionalità tra aumento di capitale sociale e partecipazione del socio. Gli strumenti finanziari partecipativi ben potrebbero avere una collocazione anche in un piano di superamento della crisi d’impresa, che ha avuto il suo sfogo nel concordato preventivo, nel piano [continua ..]
La scienza economico aziendale ha fornito un contributo rilevantissimo con riferimento, tra gli altri aspetti, alla definizione, alla prevenzione, alla previsione della crisi d’impresa, nonché in punto di strutturazione dei controlli. In particolare, la dottrina aziendalistica ha definito la crisi che consta «in quel processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di perdite di varia entità che, a loro volta, possono determinare l’insolvenza che costituisce più che la causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto» [43]. A partire da questa illuminante definizione di crisi, se ne possono indagare altri aspetti relativi all’intensità, alle cause sottostanti, alla recuperabilità dell’azienda [44]. Il processo degenerativo aziendale – in base ad un approccio graduale – può essere scomposto nelle seguenti fasi: a) declino; b) crisi; c) insolvenza; d) dissesto [45]. Il declino si manifesta tramite l’inaridimento dei flussi reddituali dovuto, sovente, all’azione congiunta della riduzione dei ricavi e alla proliferazione dei costi. Il depotenziamento delle capacità reddituali si manifesterebbe anche tramite la contrazione del valore economico del capitale d’impresa. Lo stadio successivo del processo degenerativo aziendale è rappresentato dalla crisi, che si manifesta tramite la contrazione della liquidità. In questa fase, pertanto, lo stato di difficoltà aziendale si manifesterebbe anche sotto l’aspetto finanziario. Lo stadio successivo rappresentato dall’insolvenza consta nell’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, e affinché sia superata si renderebbero necessari interventi pervasivi sovente fino alla sostituzione degli organi direttivi. Il dissesto, infine, è la manifestazione terminale della crisi e affinché si addivenga ad una soluzione i creditori subiscono una compressione dei loro crediti. A ciascuno stadio della crisi può accostarsi uno degli istituti approntati dall’ordinamento. Si può immaginare una sorta di asse ai cui estremi si collocano il piano attestato di risanamento, per situazioni di tensioni [continua ..]
Nei paragrafi precedenti si è tentato di ricostruire – secondo un approccio sistematico e ragionato – il complesso mosaico di interventi e di istituti posti a tutela della continuità aziendale. Il profluvio normativo all’uopo dedicato ha determinato gli effetti sperati dal legislatore, tant’è che il numero di fallimenti è sensibilmente diminuito [57]. Ma la crisi aziendali continuano ad imperversare nel nostro Paese, pertanto potrebbe insinuarsi il dubbio se il potenziamento dell’arsenale normativo del diritto della crisi sia la soluzione più efficace per supportare la sopravvivenza dell’impresa. In questo paragrafo si tenterà di offrire una prospettiva di tutela della continuità aziendale, che prende le mosse dalle caratteristiche intrinseche delle imprese domestiche. Queste – come del resto è noto – sono caratterizzate dalla ridottissima dimensione e dall’elevato indebitamento [58]. E proprio questi due fattori costituirebbero – sulla base dell’evidenza empirica – i principali elementi di fragilità del sistema industriale italiano. La tesi ivi prospettata consiste nella rilevante esposizione al rischio di estinzione – per effetto della liquidazione volontaria o giudiziale – delle imprese di modeste dimensioni e con una struttura finanziaria in cui è preponderante il capitale di terzi. La principale argomentazione a sostegno di questa tesi consta proprio nell’evidenza empirica. Infatti, la probabilità di fallimento delle imprese di maggiori dimensioni si attesta intorno al 3,6%. Con riferimento alle imprese più piccole, invece, la medesima probabilità è pari a circa il 7%. Si può scorgere, pertanto, l’esistenza di una relazione tra la dimensione aziendale e la probabilità di fallimento [59]. Si potrebbero tentare di scrutare le possibili ragioni alla base dei dati suesposti. L’impresa di maggiori dimensioni sarebbe meno esposta al rischio di estinzione potendo beneficiare di un maggiore sostegno finanziario dalle banche, e a condizioni migliori rispetto ad una impresa di dimensioni più modeste. Ed ancora, una grande impresa potrebbe beneficiare della diversificazione produttiva onde limitare il rischio di saturazione del mercato rispetto ad una impresa monoprodotto o, comunque, con un portafoglio prodotti [continua ..]
In questo scritto si è tentato di fornire una ricostruzione sistematica del complesso mosaico di istituti giuridici e di interventi diretti a tutela la continuità aziendale. Si è evidenziato che questo obiettivo non è collocabile solo nel campo del diritto della crisi d’impresa, ma si estende anche nel perimetro del diritto societario. Se il primo ha dispiegato un amplissimo potenziale quando la crisi è già insorta – tramite molteplici istituti giuridici regolatori – il secondo ha fornito un contributo altrettanto rilevante nella prevenzione degli eventi minatori della continuità aziendale. La recente riforma della crisi d’impresa sembra abbia colto la necessità di arretrare il raggio d’azione con uno spiccato tratto preventivo. Si pensi, ad esempio, all’estensione della platea delle società soggette all’introduzione dell’organo di controllo, nonché all’innesto nell’art. 2086 c.c. di specifici vincoli organizzativi finalizzati alla prevenzione della crisi. Ed ancora, l’influenza tra le due discipline può cogliersi anche con riferimento alla regolazione della crisi dei gruppi societari che nella legge fallimentare attualmente vigente non gode di norme specifiche. Se il testo legislativo del 1942 era imperniato sulla regolazione della crisi dell’imprenditore, la novellata cornice normativa ha avvertito l’esigenza di disciplinare la crisi dell’impresa societaria e, in particolare, del gruppo di società. Ed in questo ambito si può cogliere la presa di coscienza, da parte del legislatore, della mutata realtà economica e della crisi aziendale. Questa, infatti, spesso coinvolge società, anche di modeste dimensioni, comprese in un gruppo societario. Ne deriva che il c.d. diritto societario della crisi ha assunto contorni sempre più ampi e nitidi. La nuova disciplina della crisi d’impresa, come si è evidenziato, esalta il ruolo della pianificazione, che si estrinseca nei piani di superamento della crisi. E qui vi si innestano osservazioni di natura economico aziendale, che può apportare in questo ambito un contributo rilevantissimo. La predisposizione dei suddetti piani ha assunto una rilevanza sempre maggiore nell’ambito della scienza e della prassi aziendalistica, tanto da costituire un filone di [continua ..]
ABRIANI N.-CALVOSA L.-FERRI G. JR-GIANNELLI G.-GUERRERA F.-GUIZZI G.-MOTTI C.-NOTARI M.-PACIELLO A.-PISCITELLO P.-REGOLI D.-RESCIO G.-ROSAPEPE R.-ROSSI S.-RICHTER M.S. JR-TOFFOLETTO A., Diritto Fallimentare [Manuale breve], prefazione di Antonio Piras, Giuffrè, Milano, 2008. AMBROSINI S., La tutela dei finanziamenti all’impresa in crisi, in Trattato di Diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali – Le altre procedure concorsuali, vol. IV, Giappichelli, Torino, 2014. ANGIOLA N., Crisi d’impresa. Modelli di analisi e previsione, Dipartimento di scienze economiche, matematico-statistiche, economico-aziendali, ambientali, Lecce, 1998. ARLOTTA C.-BOCCIA A.-CODA NEGOZIO E.-DAL MASO L.-IMPARATO A.-LIBERATORE G.-PAPPALARDO G.-PARENTE F.-PASQUETTI L.-PRATI G.-RENOLDI G.-VENTURINI G.-VIRGILIO F.P., Incentivi per favorire la quotazione delle pmi sui mercati internazionali e in Italia. Opportunità e proposte, collana di Economia e Management, Franco Angeli, Milano, 2013. ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il Diritto delle Società, terza edizione, Il Mulino, Bologna, 2009. BACCELI G., La crisi d’impresa tra diritto ed economia, Mondadori, Milano, 2012. BASTIA P., Soluzioni per l’accertamento precoce della crisi, in Osservatorio-oci.org, Roma, febbraio 2018. BASTIA PAOLO, Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Giappichelli, Torino, 1996. BELLANDO F.-QUATTROCCHIO L.M., Continuità aziendale, crisi ed insolvenza nella loro dimensione evolutiva e (spesso) degenerativa, in Diritto ed economia dell’impresa, Giappichelli, Torino, n. 1/2017. BIANCHI M.T., I patrimoni dedicati tra novità e tradizione, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8, Roma, 2003. BIGAZZI S., MANGANI A., Problema dimensionale e politica industriale: gli incentivi governativi alle fusioni, in Rivista Piccola Impresa/Small Business – n. 2/2010. BINI M., La valutazione nelle crisi e nelle situazioni di insolvenza delle imprese, in La valutazione delle aziende, n. 1/2019. BRIZZI F., L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi; V Convegno annuale dell’associazione italiana dei professori di diritto commerciale, in Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma, [continua ..]