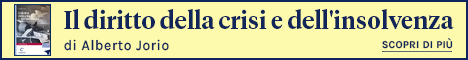
Nell’ambito dei contratti di investimento, la questione dell’uso selettivo della nullità di protezione, prevista in caso di violazione della forma scritta, è argomento che ha sollevato rilevanti contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La pronuncia delle Sezioni Unite sull’ammissibilità della nullità selettiva offre l’occasione di esaminare i tratti tipici di tale nullità e delle conseguenze che derivano dall’applicazione del principio di buona fede. In tale prospettiva di analisi, l’autore, dopo aver richiamato i principi diritto espressi dalle Sezioni Unite, si sofferma sulla buona fede, intesa quale clausola generale di comportamento delle parti, nonché sull’applicazione di tale principio in chiave riequilibratrice. Infine, l’autore completa il quadro di analisi con approfondite riflessioni conclusive sulla nullità selettiva e sulla valorizzazione del principio di buona fede.
Within the context of investment contracts, the question of the selective use of the nullity of protection, provided for in the event of violation of the written form, is a topic that has raised significant contrasts both in doctrine and jurisprudence. The ruling of the United Sections of the national Court of Justice on the admissibility of selective nullity offers the opportunity to examine the typical features of this nullity and the consequences that derive from the application of the principle of good faith. In this perspective of analysis, the author, after recalling the principles of law expressed by the United Sections of the national Court of Justice, dwells on good faith as a general clause of behaviour of the parties, as well as on the application of this principle in a rebalancing key. At the end, the author completes the analysis with in-depth conclusive reflections on selective nullity and on the enhancement of the principle of good faith.
1. Premessa - 2. L’orientamento della Suprema Corte: il principio di buona fede come criterio ordinante - 3. Una digressione sulla buona fede come clausola generale di comportamento delle parti - 4. L’applicazione del principio di buona fede in chiave riequilibratrice - 5. Riflessioni conclusive sulla nullità ex art. 23 t.u.f. - NOTE
Nell’ambito dei contratti di investimento, la questione dell’uso selettivo della nullità di protezione, prevista dall’art. 23 t.u.f. in caso di violazione della forma scritta, è argomento che ha sollevato rilevanti contrasti in dottrina e in giurisprudenza. Il tema sorge nell’ambito dei contratti di investimento per due ordini di ragioni. La prima è la negoziazione bifasica caratterizzante i servizi di investimento, poiché essa comporta che la nullità per difetto di forma del contratto quadro si riverberi a cascata sui singoli ordini, impartiti (anche in forma orale) dal cliente. La seconda consiste nell’operatività “a vantaggio del solo cliente” della nullità di protezione ex art. 23 t.u.f. e, quindi, nella legittimazione esclusiva all’azione. La pronuncia delle Sezioni Unite sull’ammissibilità della nullità selettiva offre l’occasione di esaminare i tratti tipici della nullità prevista dall’art. 23 t.u.f. e le conseguenze che derivano dall’applicazione del principio di buona fede ad un precetto di forma, che si pone a metà strada tra le regole di comportamento e le regole di validità.
Con la sent. del 4 novembre 2019, n. 28314 [1], la Corte di legittimità torna ad affrontare la spinosa questione della “nullità selettiva” nei contratti di investimento ed individua la buona fede come criterio guida del ragionamento. La pronuncia ribadisce il principio della legittimazione esclusiva del contraente debole in funzione protettiva, ma mette l’accento sul comportamento del cliente e, in particolare, sulle diverse declinazioni dell’obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. In questo contesto, risulta valorizzata l’analisi della complessiva esecuzione degli ordini, successiva alla conclusione del contratto quadro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, i tratti unificanti delle nullità di protezione [2] si rinvengono nell’operatività a vantaggio della parte debole e nella rilevabilità ope iudicis, pur nel limite dell’interesse del titolare del diritto all’azione. Tale interpretazione è stata proposta dalla Sezioni Unite nella nota sent. n. 26642/2014 [3], in applicazione all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea [4]. In particolare, si è chiarito che la nullità di protezione deve considerarsi una species del più ampio genus delle nullità negoziali, giacché tutelano interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato ex art. 41 Cost. e l’uguaglianza formale tra contraenti ex art. 3 Cost., poiché l’asimmetria negoziale altera non solo i presupposti dell’autonomia contrattuale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra le imprese. Pur accogliendo tale orientamento, la Suprema Corte ha rilevato che la nullità di protezione, essendo nata in riferimento alla correzione parziale del contratto in virtù dell’inefficacia delle clausole vessatorie, mal si adatta all’invalidità dell’intero contratto quadro, la cui conformazione bifasica pone, appunto, il problema della nullità selettiva. Tali criticità sono le stesse che avrebbero condotto la giurisprudenza di legittimità, in una precedente pronuncia, ad assumere un criterio interpretativo funzionalistico, riconoscendo la validità del contratto sottoscritto dal solo cliente – il c.d. [continua ..]
Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite si verte chiaramente in un’ipotesi di nullità rispetto alla quale, con un passaggio per certi versi innovativo, ma non da tutti condiviso, la Corte di legittimità attribuisce rilevanza ad una regola comportamentale che andrebbe a intersecarsi ad una regola di validità. Invero, l’obbligo di buona fede è annoverabile tra le regole di comportamento, le quali, secondo l’insegnamento tradizionale, non si possono mai tradurre nella nullità, ma unicamente nel risarcimento del danno e nella risoluzione per inadempimento, a differenza delle regole di validità che incidono sui profili strutturali [6]. In dottrina, tuttavia, è stato rilevato che le nullità di protezione, essendo ispirate al principio di correttezza, si distanziano dalla nullità strutturale tipicamente codicistica. Secondo un noto e recente contributo, che richiama questa impostazione, infatti, bisognerebbe valorizzare “il criterio di correttezza e, con esso, introdurre una connotazione di flessibilità operativa delle conseguenze della violazione” [7]. Tale flessibilità consentirebbe, quindi, di scindere il piano degli effetti della nullità da quello della validità e dell’esistenza, cosicché il contratto nullo si concretizzi come “una fattispecie da cui il diritto fa derivare delle conseguenze (principalmente negative)” [8], sfumando i confini tra regole di validità e regole di comportamento [9]. La dottrina, interpretando la pronuncia sul c.d. contratto mono-firma, ha in seguito escluso che la forma prescritta dall’art. 23 t.u.f. sia una forma ad substantiam actus e, di conseguenza, che la nullità sia riconducibile allo schema del combinato disposto degli artt. 1325, n. 4 e 1418, comma 2, c.c. Più precisamente, si è sostenuto che ricusare la sottoscrizione di entrambi i contraenti quale elemento essenziale della forma prescritta per la validità sarebbe una “affermazione palesemente contraddittoria ed evidentemente erronea” [10]. Infatti, “non si può immaginare invece che – all’interno del medesimo ordinamento – coesistano “concetti” diversi e incompatibili tra di loro, che possano cionondimeno considerarsi qualificatori del medesimo fenomeno” [11]. Di [continua ..]
L’uso del principio di buona fede “in chiave riequilibratrice” non è nuovo nella giurisprudenza pronunciatisi in tema di esercizio selettivo dell’azione di nullità. In particolare, la Corte di legittimità aveva già auspicato la necessità di indagare l’operatività dell’eccezione di dolo avverso la condotta “selettiva” del cliente, considerato in malafede [13], avendo da tempo ammesso l’esperibilità di tale rimedio nel caso di esercizio fraudolento e sleale dei diritti [14]. Prima ancora, la giurisprudenza di merito, nonché parte della dottrina [15], aveva proposto il ricorso all’abuso del diritto, strumento che, prescindendo dal dato soggettivo, consentirebbe di paralizzare l’azione ogniqualvolta quest’ultima sia incoerente con lo scopo della norma. Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sent. n. 28314/2019 citata, in parte si discostano da tali orientamenti, assumendo un diverso “parametro … univoco e coerente”: ossia la differenza tra il petitum azionato (o il pregiudizio subito dal cliente) e i risultati vantaggiosi derivanti dagli ordini rimasti fuori dal procedimento. Secondo il giudizio della Suprema Corte, l’investitore avrebbe “agito coerentemente con la funzione tipica delle nullità protettive”, solamente ove permanga un pregiudizio rispetto ai risultati positivi derivanti dagli ordini di investimento non azionati. Diversamente, l’azione del cliente si dimostra “oggettivamente finalizzat[a] ad arrecare un pregiudizio all’intermediario” e per questo meriterebbe di essere paralizzata mediante “l’eccezione di buona fede”. La dottrina non ha accolto favorevolmente tale interpretazione, giacché equivarrebbe a sostenere che la violazione del principio di buona fede si configuri ogniqualvolta il titolare dell’azione agisca conseguendo un risultato economico positivo [16]. Secondo tale critica, infatti, “per un qualsiasi contraente, diverso dall’investitore, il fatto di impugnare questo o quell’atto, è normale, e dovrebbe esserlo anche per l’investitore” [17]. Pertanto, una spiegazione che consenta di superare tale criticità potrebbe essere quella che riqualifichi l’effetto prodotto dal comportamento del cliente (l’eccessivo pregiudizio [continua ..]
La valorizzazione dell’obbligo di buona fede non dovrebbe giungere a scardinare la funzione di tutela del contraente debole prevista dall’art. 23 t.u.f. A tal proposito, appare rilevante un dato sottolineato dalla dottrina: le parti non sono parimenti considerate dal legislatore. Invero, la nullità di protezione opera “a vantaggio” del (solo) cliente, sbilanciando (non pareggiando) la tutela a suo favore [30], tanto che la giurisprudenza di legittimità ammette a monte l’esperibilità dell’azione selettiva. Il nucleo caratterizzante la nullità di protezione è quindi l’operatività a vantaggio del contrente debole, sia dal punto di vista processuale che sostanziale. In questi termini, (tutti) gli effetti selettivi della nullità sono strutturali alla conformazione normativa di tale forma di protezione, proprio perché il legislatore mira a sbilanciare la tutela nel momento stesso in cui commina la sanzione [31]. Non sembra possibile superare tale dato richiamando l’obbligo di lealtà del cliente nel fornire le informazioni necessarie all’intermediario per adempiere ai propri obblighi informativi. Infatti, si tratta di un dovere che può ricavarsi dalla disciplina generale dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e che costituisce il contraltare di un obbligo in realtà diverso dell’intermediario: ossia la corretta profilazione o, se si vuole, il versante “sostanziale” (non formale) della tutela, per il quale sono esperibili i rimedi tipici previsti per la violazione delle regole di comportamento [32]. Inoltre, appare preferibile l’orientamento dottrinale che pone l’accento sulla funzione sanzionatoria della nullità ex art. 23 t.u.f., la quale sarebbe volta a reprimere e migliorare prassi non virtuose [33]. Ciò potrebbe ricavarsi dalla scelta del legislatore di sconfessare il classico rimedio del risarcimento del danno a fronte della violazione di un precetto che, a seguito delle elaborazioni giurisprudenziali, sembra più una regola di comportamento che di validità, collegando la violazione dell’obbligo ad un rimedio demolitorio, quale è la nullità. Ed allora, la ragione potrebbe rinvenirsi in una necessità di ordine generale: “è proprio l’ordine pubblico che richiede la protezione dell’interesse privato (e [continua ..]