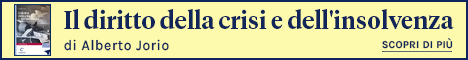
Gli autori affrontano la disciplina civilistica dell’attività di direzione e coordinamento – introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003 –, di concerto con un’analisi del reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c. e della disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento nelle transazioni infragruppo di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. Obiettivo dell’elaborato è mettere in luce, attraverso l’individuazione dei possibili punti di interazione tra la disciplina di cui agli artt. 2497 ss. c.c. e quelle penale dell’infedeltà patrimoniale e tributaria del transfer pricing, l’intento del legislatore di contrastare – appunto, sotto diversi profili – gli (eventuali) effetti distorsivi dell’attività di direzione e coordinamento.
The authors examine the civil law of direction and coordination activity – introduced by the 2003 corporate law reform –, in concert with an analysis of the crime of patrimonial unfaithfulness pursuant to article 2634 of the Italian Civil Code and the tax regulation of transfer prices in intragroup transactions pursuant to article 110, paragraph 7, TUIR. The objective of the paper is to highlight, through the identification of possible points of interaction between the regulation referred to in articles 2497 et seq. of the Italian Civil Code and the criminal and tax ones of patrimonial unfaithfulness and transfer pricing respectively, the intent of the legislator to combat – precisely, from different points of view – the (possible) distorting effects of direction and coordination activity.
Keywords: corporate group – direction and coordination – intragroup transaction.
Articoli Correlati: gruppo societario - direzione e coordinamento - transazioni infragruppo
1. Premessa - 2. La disciplina civilistica dell’attività di direzione e coordinamento - 2.1. Il quadro normativo - 2.2. I profili di responsabilità - 2.3. La teoria dei vantaggi compensativi - 3. Il reato di infedeltà patrimoniale - 4. La disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento - 4.1. Le possibili interazioni con la disciplina civilistica - 4.2. La disciplina in tema di transfer pricing - 4.3. Segue. La nozione di valore normale - 4.4. I modelli di determinazione del valore normale - 4.5. Gli obblighi di dichiarazione - 4.6. La disciplina sanzionatoria - 4.7. Segue. La rilevanza penale delle violazioni - 5. Conclusioni - NOTE
Come è noto, il legislatore della riforma del diritto delle società di capitali ha introdotto – nel 2003 – una compiuta disciplina dell’attività di direzione e coordinamento. Invero, tale intervento legislativo era stato preceduto – nel 2002 – dalla novella dell’art. 2634 c.c. in tema di reato di infedeltà patrimoniale. Tuttavia, prima ancora, il legislatore tributario aveva introdotto una dettagliata regolamentazione dei prezzi di trasferimento nelle transazioni infragruppo internazionali. Attraverso un sintetico richiamo dei tratti caratterizzanti le citate discipline, si intende – con il presente contributo – mettere in evidenza come l’obiettivo del legislatore sia quello di contrastare – sotto i diversi profili – gli eventuali effetti distorsivi dell’attività di direzione e coordinamento.
L’ordinamento italiano non conteneva (e tuttora non contiene) una definizione di gruppo né tantomeno una disciplina organica in materia, ma si limitava – sino alla Riforma del diritto societario – a dettare la nozione di imprese controllate e collegate (art. 2359 c.c.), oltre ad individuare i soggetti ricompresi nell’area di consolidamento (art. 26 d.lgs. n. 127/1991). La motivazione di tale scelta andava – e va tuttora – ricercata nella finalità del Legislatore di non costringere gli operatori economici e gli interpreti in una tipizzazione rigida e vincolante di un fenomeno in rapido e continuo mutamento, per effetto di nuove forme organizzative e partecipative. Il Legislatore della Riforma del diritto societario nel 2003 ha – in parte colmato la lacuna dell’ordinamento in tale materia – introducendo nel Codice Civile, il Capo IX rubricato “Direzione e coordinamento di società” e individuando una serie di adempimenti, obblighi e vincoli con l’obiettivo di tutelare i terzi e i soci di minoranza delle imprese controllate. La disciplina complessiva che ne è scaturita, è caratterizzata dai seguenti obblighi [1]: obbligo di corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte dell’ente controllante (art. 2497-bisc.c.); obbligo di pubblicità e comunicazione per le società che subiscono la direzione unitaria (art. 2497-bisc.c.); obbligo di redazione – da parte delle società controllate – di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio dell’ente che esercita su di loro l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis,comma 4, c.c.); obbligo di indicazione nella relazione sulla gestione – da parte degli amministratori delle controllate – dei rapporti intercorsi con l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, oltre all’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio delle società e sui loro risultati (art. 2497-bis, comma 5, c.c.). Tali norme sono state introdotte con l’obiettivo di stabilire fino a che punto l’interesse del gruppo possa prevalere su quello delle singole società (od enti) facenti parte, al fine di garantire la tutela dei soci di minoranza e dei creditori sociali, anche [continua ..]
Il legislatore della Riforma del diritto societario è intervenuto prevedendo ipotesi di responsabilità in capo all’ente che esercita attività di direzione e coordinamento sotto diversi profili: verso i soci, per i danni da questi sofferti per il mancato aumento della redditività o per la diminuzione di valore della partecipazione; verso i creditori della società, quando tale esercizio provochi l’insufficienza del patrimonio di quella eterodiretta a garantire le ragioni creditorie. In particolare la tutela dei soci (specialmente di minoranza) della società eterodiretta è riconosciuta dall’art. 2497 c.c., nei seguenti termini: «le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale». Da una prima lettura emerge chiaramente che l’art. 2497 c.c. – ispirato ad una logica di compromesso tra considerazione unitaria del gruppo e valorizzazione dell’autonomia delle singole società che ne fanno parte – se, da un lato, presuppone la legittimità dell’attività di direzione e coordinamento (quale attività fisiologica della holding nel gruppo), dall’altro la subordina al rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società eterodiretta, a tutela dei soci di minoranza e dei creditori di quest’ultima. L’attività di direzione e coordinamento incontra, dunque, un duplice limite: in primo luogo il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento non può imporre un risultato che non sia coerente con l’oggetto sociale e con la «necessaria configurazione della società quale entità economica che potenzialmente deve operare in competizione sul mercato»; in secondo luogo, esso non può restringere oltre misura l’autonomia degli amministratori, al punto da svuotarne i poteri gestionali. Evidentemente, qualora il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento non rispetti il primo limite, può [continua ..]
Si è già avuto modo di sottolineare come il legislatore – nell’art. 2497, comma 1, c.c. – abbia voluto espressamente escludere la responsabilità nel caso in cui il danno risulti mancante alla luce di una visione complessiva del risultato dell’attività di direzione e coordinamento. L’eliminazione del danno, anche a seguito di operazioni a ciò dirette, sembrerebbe configurare – si è osservato – un’ipotesi di intervenuto risarcimento per equivalente, tale da far venir meno il pregiudizio e dunque la possibilità di far valere la responsabilità. In tema di compensazione si profilano due orientamenti diversi: quello favorevole ad una compensazione effettiva, per cui l’atto è lecito solo se la società danneggiata ha ricevuto un vantaggio reale e diretto; e quella che si accontenta di una compensazione virtuale, ritenendosi sufficiente che la società avvantaggiata dalla politica di gruppo abbia conseguito un vantaggio, che consentirebbe di compensare – a livello di gruppo – il danno di quella svantaggiata. Per altro verso, il rinvio esplicito che l’art. 2497 c.c. rivolge alla clausola generale di correttezza può essere considerato un indice – non solo testuale ma sistematico – a favore della tesi contrattualistica. È, infatti, nell’essenza stessa dei rapporti tra soci che trova applicazione il principio generale di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), la cui funzione regolatrice diventa ancora più pregnante allorquando si riferisca allo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento che rappresenta, per l’appunto, un momento di esecuzione del contratto sociale [6]. Considerato che nella maggior parte dei casi chi esercita l’attività di direzione e coordinamento pregiudizievole è il socio di maggioranza, la violazione delle regole di correttezza nella gestione societaria e imprenditoriale infrange il contratto sociale con i consoci (e in particolare con quelli di minoranza). L’interesse dei soci di minoranza (alla redditività e alla valorizzazione della partecipazione sociale) e dei creditori (all’integrità del patrimonio) assume la natura di “aspettativa” all’adempimento di un determinato comportamento di terzi e, cioè, presuppone che [continua ..]
[9] Un ulteriore profilo di responsabilità, questa volta personale, può essere individuato in capo agli amministratori della capogruppo – ed eventualmente delle società controllate – in forza dell’art. 2634 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 61/2002, che disciplina il reato di infedeltà patrimoniale. L’art. 2634 c.c. prevede che gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, i quali, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni; la stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. Volendo procedere ad un’analisi – seppure sommaria – degli elementi della fattispecie, occorre – in prima battuta – prendere in considerazione la necessaria sussistenza di un interesse del soggetto agente in conflitto con quello della società. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «si ha conflitto di interessi ogni qual volta si faccia valere un interesse collidente con quello della società, come nel caso in cui l’amministratore si ponga in una posizione antagonista rispetto all’ente, quale controparte contrattuale» [10]. Quanto al concetto giuridico di interesse sociale va rilevato come, almeno in relazione alla precedente fattispecie, ma con ragionamento presumibilmente trasponibile alla nuova, abbia preso il sopravvento una visione contrattualistica, secondo cui esso consisterebbe «nell’interesse comune dei soci e, più precisamente, nell’interesse di costoro alla realizzazione dello scopo della società, id est al conseguimento di utili per il tramite della realizzazione dell’oggetto sociale. Pur così inteso, tuttavia, l’interesse sociale non sembra possa essere considerato come equivalente alla semplice risultante aritmetica degli interessi particolari dei singoli soci». [11] Si [continua ..]
La disciplina civilistica in tema di attività di direzione e coordinamento può assumere rilevanza nell’ambito di talune fattispecie di natura fiscale, la cui regolamentazione interagisce con le previsioni di cui agli artt. 2497 ss. c.c.; in primo luogo, il tema dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, TUIR, il quale individua la possibilità dell’amministrazione finanziaria di rideterminare sulla base del valore normale le transazioni internazionali aventi ad oggetto beni e servizi. È importante sottolineare che l’art. 110 TUIR non richiama la disciplina civilistica, limitandosi a fissare specifici obblighi nella determinazione del reddito o della perdita fiscalmente rilevante ai fini IRES con l’obiettivo di annullare gli effetti distorsivi che i prezzi di trasferimento potrebbero generare. In particolare, lo scopo della disciplina è diretta ad evitare che all’interno del gruppo vengano posti in essere trasferimenti di utili tramite applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti onde sottrarli alla tassazione in Italia. La Suprema Corte, con sentenza n. 22023 del 22 giugno 2006, ha assimilato l’art. 110, comma 7, TUIR, alla clausola antielusiva generale, di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973: in particolare, ha ritenuto necessario verificare – anche in materia di transfer pricing – l’eventuale sussistenza di un indebito risparmio d’imposta, in chiave antielusiva. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 240005 del 23 ottobre 2013, è nuovamente intervenuta in tema di transfer pricing: in particolare, ha ribadito che l’art 110, comma 7, TUIR costituisce espressione del principio per cui ove i corrispettivi pattuiti dalle parti della singola transazione commerciale siano manipolati a danno del Fisco italiano, in particolare nel caso di scambi transnazionali infragruppo, debbano essere sostituiti con il valore normale dei beni e dei servizi oggetto dello scambio; ciò al fine di impedire il dirottamento di flussi reddituali verso Paesi a fiscalità agevolata. È opportuno ancora rammentare che la Suprema Corte, con la sentenza n. 17955 del 24 luglio 2013, si è pronunciata in termini di abuso del diritto e di riserva di legge con specifico riferimento al cosiddetto transfer pricing “domestico”, cioè quello che [continua ..]
Come risulta dall’esito della consultazione pubblica lanciata nell’aprile del 2010 dalla Commissione Europea e da recenti studi OCSE, più del 70% degli scambi commerciali transnazionali avviene tra le società appartenenti al medesimo gruppo e ciò in ragione della sempre più evidente tendenza dei gruppi a segmentare per motivi organizzativi e di convenienza economica le tipiche fasi in cui si articola l’attività produttiva, affiancandole al proprio interno a società distinte e il più delle volte residenti in Stati diversi [12]. Il fine principale delle disposizioni sul transfer pricing emanate dagli ordinamenti interni e dagli organismi sovranazionali (tra cui l’OCSE) è quello di evitare che le multinazionali pervengano, attraverso una sovrastima o una sottostima dei prezzi, al trasferimento di porzioni di reddito imponibile in Stati a fiscalità ridotta o in cui l’impresa multinazionale vanta (o potrebbe vantare) uno specifico interesse. La disciplina nazionale dei prezzi di trasferimento è contenuta – come si è detto – nell’art. 110, comma 7, e nell’art. 9 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [13]. L’art 110, comma 7, TUIR recita: «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti». A norma del citato articolo i componenti di reddito che derivano da operazioni con società non [continua ..]
L’art. 9 del TUIR recita: «Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.». Il concetto di valore normale espresso dall’art. 9 TUIR recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza OCSE, con i relativi criteri di determinazione. Ne consegue che i soggetti legati tra loro da rapporti di natura giuridica o economica e le imprese autonome sono sottoposti ad un prelievo fiscale uniformemente determinato. La norma citata, per la determinazione del valore normale individua in via preferenziale il metodo del confronto del prezzo (CUP), la cui disciplina si articola nella prima e seconda parte del terzo comma dello stesso articolo. La Suprema Corte è intervenuta più volte al fine di delimitarne l’ambito applicativo. In particolare, con la sentenza 31 marzo 2011, n. 7343, ha affermato che non rientrano nei c.d. “sconti d’uso” contemplati dall’art. 9, comma 3, TUIR le riduzioni percentuali del prezzo praticate nei soli rapporti economici con società del gruppo. In relazione al rapporto tra i criteri delineati per stabilire il valore normale dei corrispettivi, con la sentenza n. 22010 del 25 settembre 2013, è stato affermato che quello prioritario risiede nella seconda parte della norma citata, la quale richiede di prendere in considerazione, in via principale i listini e le tariffe del venditore dei beni o del prestatore di servizi, tenuto conto anche degli sconti che eventualmente lo stesso è disposto a concedere nel mercato di appartenenza e, solo in via subordinata, ovvero in caso di inesistenza, inapplicabilità o inattendibilità del listino o della tariffa, i mercuriali ed i listini della Camera di [continua ..]
Come si è detto, il “valore normale” è il parametro di valutazione che deve essere utilizzato per determinare il prezzo delle transazioni infragruppo di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. L’OCSE ha individuato diversi metodi per la determinazione di tale valore, suddividendoli in metodi tradizionali e metodi reddituali. I metodo tradizionali sono i seguenti: il metodo del confronto del prezzo (cup), che determina il valore della transazione che imprese del gruppo avrebbero potuto convenire con soggetti terzi. Tale approccio si rende inapplicabile nel caso in cui le transazioni intercorrenti tra imprese libere presentino caratteristiche tali da non essere comparabili con quelle infra-gruppo; il prezzo di rivendita (resale minus) e il costo maggiorato (cost plus), che comparano i margini lordi conseguiti nelle operazioni in verifica con quelli realizzati da imprese indipendenti svolgenti le stesse funzioni economiche in termini diasset utilizzati e rischi assunti. I metodi reddituali raffrontano i margini netti conseguiti in transazioni infra-gruppo con quelli che avrebbero realizzato le medesime imprese ove avessero operato con terzi. L’OCSE consente l’utilizzo dei metodi reddituali soltanto in determinate circostanze. Infatti, confermando la superiorità dei metodi tradizionali rispetto ai risultati derivanti dall’applicazione di quelli reddituali, l’OCSE ammette che la complessità delle situazioni di mercato può determinare delle difficoltà pratiche e riconosce, dunque, che «in situazioni eccezionali dove non sono disponibili informazioni di qualità non sufficiente per affidarsi ai metodi tradizionali, può diventare necessario verificare se e a quali condizioni altri metodi possono essere utilizzati» [18]. I criteri e i modelli determinati dagli Organismi internazionali e segnatamente dall’OCSE per determinare i prezzi di trasferimento – come precedentemente descritto – non hanno un precipuo scopo antielusivo, ma piuttosto quello di risolvere i conflitti fra giurisdizioni per ripartire in modo equilibrato le rispettive pretese impositive e, in quest’ottica, aiutare i gruppi a vocazione internazionale a superare i problemi della doppia imposizione, ad acquisire maggiori certezza, si da sviluppare il loro business senza ostacoli fiscali [19]. Tuttavia, occorre riconoscere il crescente [continua ..]
La disciplina in materia di prezzi di trasferimento – come precedentemente riferito – è contenuta nell’art. 110, comma 7, TUIR. L’Agenzia delle Entrate, in apposite comunicazioni e nelle istruzioni del modello Unico, ha preso in esame il tema, fornendo delucidazioni ai contribuenti. La compilazione da parte del contribuente dei quadri relativi ai prezzi di trasferimento in sede di dichiarazione dei redditi assume valore di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate; con essa, infatti, si dichiara di essere in possesso della adeguata e conforme documentazione. Tale considerazione appare particolarmente importante, in quanto costituisce il presupposto essenziale per accedere al regime premiale, che esclude l’applicazione delle sanzioni in caso di relativo accertamento. In particolare, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione di Unico SC 2015, il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso della documentazione barrando la casella 4, del rigo RS 106, dell’Unico SC 2015, denominata “Possesso documentazione”, nonché l’indicazione della qualifica di impresa controllata o controllante. Inoltre, è opportuno indicare nelle colonne 5 e 6 del rigo RS 106, rispettivamente l’ammontare complessivo dei componenti di reddito positivi e negativi derivanti da operazioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. Oltre alle indicazioni da fornire nel Quadro RS, il contribuente – qualora in sede di predisposizione degli oneri documentali ci si accorga che le operazioni con società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non siano avvenute nel rispetto del valore normale – deve apportare le variazioni in aumento e in diminuzione in Unico 2015. In particolare: • se dall’applicazione del valore normale deriva un aumento della base imponibile, le istruzioni del Modello Unico 2015 prevedono l’indicazione, nel Rigo RF 31 di UNICO SC 2015 utilizzando il codice 15, della differenza negativa tra il ricavo contabilizzato e il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati; • se dall’applicazione del valore normale deriva una riduzione del reddito imponibile, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza positiva tra il ricavo contabilizzato e il valore normale dei beni [continua ..]
La disciplina sanzionatoria in materia di transfer pricing si sostanzia nell’applicazione della disposizione introdotta dall’art. 26 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disposizione prevede la disapplicazione automatica delle sanzioni tributarie, in materia di determinazione di maggiori imponibili conseguenti all’applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento, nel caso in cui il contribuente renda disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato in data 29 settembre 2010. Le differenti tipologie di documentazioni, identificate dal provvedimento, quindi ritenute idonee secondo i termini di legge, sono: • Masterfile, che raccoglie le informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso; • Countryfile, quale documento nazionale che integra con il Masterfile la documentazione idonea e che contiene informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare. Trova applicazione anche in questo caso la considerazione che i relativi contenuti sostanziali dovranno essere elaborati in coerenza con le Linee Guida OCSE. Alla documentazione devono essere allegati: un diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni, anche straordinarie e le copie dei contratti scritti che regolano le transazioni infragruppo. La Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 precisa che il regime documentale in commento risulta diversificato a seconda che lo stesso venga adottato da una società holding, da una sub-holding, o da un’impresa controllata. Sono inoltre previste specifiche indicazioni per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e alleggerimenti dell’onere della prova. Il Provvedimento 29 settembre 2010 precisa, altresì, che la documentazione deve essere fornita in formato elettronico, e non cartaceo. L’esibizione della documentazione cartacea non pregiudica, però, l’esclusione delle sanzioni a condizione che il contribuente, in un tempo congruo, predisponga e renda disponibile la documentazione in formato elettronico. La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria [continua ..]
L’applicabilità delle sanzioni penali non è sottesa ad una disciplina specifica, bensì può farsi rientrare nella più ampia tematica delle sanzioni relative alle fattispecie elusive e valutative in genere. A tal proposito però, occorre rammentare la particolarità della disposizione sul transfer pricing, la quale non è una norma procedurale – come avviene nel caso della norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 – bensì una disposizione inserita nel TUIR che indica la modalità di determinazione della base imponibile da riportare in dichiarazione. In proposito, la dottrina è concorde nel ritenere che le condotte in esame possano effettivamente integrare – sempre che siano superate le soglie quantitative di cui all’art. 7 – le fattispecie di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000, in quanto trattasi di “valutazione estimativa”. Tuttavia, con riferimento alla sussistenza del reato di dichiarazione infedele, ex art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, è possibile rilevare incongruenze insanabili tra quanto riportato nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e la presenza del dolo specifico atto a configurare la fattispecie di evasione. Benché l’art. 26 del d.l. n. 78/2010 nulla dica in merito alla possibilità per i contribuenti virtuosi di evitare anche le sanzioni penal-tributarie previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, si dovrebbe tener conto del comportamento collaborativo del contribuente che ha predisposto una documentazione idonea a consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo fiscale e, per tale ragione, potrebbe attenuarsi il profilo del dolo specifico.
Con l’introduzione dell’art. 2497 c.c. e prima ancora dell’art. 2634, comma 3, c.c., il legislatore ha riconosciuto un ampio margine di liceità delle operazioni infragruppo, specificando – come precedentemente esposto – quali siano i criteri per definirne i confini. In particolare, nel primo caso il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Sembra riconoscersi in tal senso una posizione di dominio della capogruppo. Per verificare se sussiste un danno, l’interprete dovrà guardare non già alla singola operazione depauperativa singolarmente considerata, ma sarà tenuto ad estendere la sua analisi al più ampio concetto di gruppo. Così facendo l’oggetto dell’accertamento si amplia e il giudizio si protrae nel tempo. Dal punto di vista penale, il d.lgs. n. 61/2002 muove dai medesimi presupposti; tuttavia, il carattere necessariamente frammentario e sussidiario della normativa penalistica porta il legislatore ad utilizzare tecniche descrittive del fatto tipico inevitabilmente diverse rispetto a quelle che contraddistinguono le previsioni civilistiche. Così, la scelta di collegare la responsabilità penale al carattere ingiusto del profitto piuttosto che alla sussistenza di un danno lascia intendere come l’ambito di intervento punitivo sia (volutamente) più ristretto: non si guarda solo al disvalore di evento, in termini di effettiva lesione al patrimonio, ma anche al particolare modus operandi. Mentre l’art. 2497 c.c. collega la responsabilità civile al pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore delle partecipazioni sociali (tutela dei soci), o alla lesione dell’integrità del patrimonio della società (tutela dei creditori sociali), l’art. 2634 c.c. non punisce qualsiasi operazione che abbia cagionato un danno patrimoniale all’ente, ma solo quella che sia stata realizzata dall’amministratore nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, mediante una condotta di abuso [20]. In tale contesto normativo devono essere calati gli accordi di natura prevalentemente fiscale, attraverso i quali può realizzarsi l’attività di direzione e coordinamento, in particolare mediante l’imposizione [continua ..]