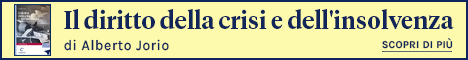
L’elaborato propone un’analisi approfondita del tema della responsabilità – sia civile, sia penale – del dottore commercialista (e dell’esperto contabile), avuto riguardo alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento. La trattazione prende avvio dalla natura del rapporto professionale fra il commercialista e il cliente, per poi proseguire – in tema di responsabilità civile – con l’analisi della responsabilità contrattuale e dei relativi obblighi del professionista, nonché con una sintesi della disciplina applicabile. Gli autori forniscono – altresì – una definizione di responsabilità extracontrattuale e del danno patrimoniale. Successivamente, il saggio illustra i diversi profili di responsabilità, avuto particolare riguardo all’assunzione di cariche societarie, incarichi giudiziali, di attività di advisory, nonché allo svolgimento di attività in materia tributaria. La trattazione si conclude con l’esame dei profili di responsabilità penale e dell’esercizio abusivo della professione.
The paper offers an in-depth analysis of the issue of professional liabilities – both civil and penal – of the chartered accountant, with specific reference to the regulatory and legal framework. The dissertation starts from the juridical nature of the relationship between chartered accountant and customer; then – within the context of civil liability – it analyses the issue of contractual liability and requirements of professional diligence, and it sum up some topics related to the legislation applicable. Moreover, the authors provide a definition of non contractual liability and of property damages. Subsequently, the paper provides an analysis of different cases of liability, with specific reference to corporate offices, judicial appointment, advisory and tax activities. At the end, the authors examine the penal liability and illegal exercise of the profession of chartered accountant.
1. Natura del rapporto professionale tra il commercialista e il cliente. Il contratto d’opera intellettuale - 2. La responsabilità civile del commercialista - 2.2. La responsabilità contrattuale - 2.2.2. L’obbligo di completa informazione - 2.2.3. Disciplina applicabile - 2.3. La responsabilità extracontrattuale - 3. Il danno patrimoniale - 4. I diversi profili di responsabilità - 4.2. L’assunzione di cariche societarie - 4.3. L’assunzione di incarichi giudiziali - 4.4. L’assunzione dell’incarico di advisor - 4.5. L’attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria - 4.5.2. L’assistenza tecnica dinanzi le Commissioni Tributarie - 4.5.3. La violazione di norme tributarie - 4.6. La verifica dei dati forniti dal cliente ai fini fiscali e contabili - 5. La responsabilità penale - 6. L’esercizio abusivo della professione - NOTE
L’oggetto dell’attività del dottore commercialista (e dell’esperto contabile) trova puntuale descrizione nell’art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, di “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”, entrato in vigore in data 3 agosto 2005. L’articolo, innanzitutto, fornisce un dettaglio delle attività oggetto della professione e, successivamente, individua le attività rientranti nella specifica competenza tecnica dei commercialisti (comma 3) e degli esperti contabili (comma 4). L’elencazione non ha – tuttavia – carattere tassativo e non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale riconosciuta ai dottori commercialisti da ulteriori interventi legislativi. Per quanto riguarda la natura del rapporto professionale che viene ad instaurarsi tra il commercialista e il cliente, questo rientra nel “contratto d’opera intellettuale”, disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. e, in quanto compatibili, dagli artt. 2222 ss. c.c., recanti le disposizioni generali del lavoro autonomo, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali. Le peculiarità del contratto d’opera intellettuale, oltre all’assenza di vincoli di subordinazione, alla discrezionalità sulle modalità di esecuzione della prestazione e alla predominanza del lavoro intellettuale su quello manuale, possono essere sintetizzate come segue: subordinazione dell’esercizio di alcune professioni intellettuali all’iscrizione in appositi albi o elenchi, che attestano la competenza del professionista, la cui tenuta è demandata agli ordini e ai collegi professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente (art. 2229 c.c.). Sono le cd. “professioni regolamentate”, di cui fa parte anche quella del commercialista[1] (sulla responsabilità per esercizio abusivo della professione, si v. infra); carattere personale della prestazione. L’art. 2232 c.c. prevede l’obbligo del professionista di eseguire personalmente l’incarico assunto, pur consentendo a questi di avvalersi di sostituti e ausiliari, purché sotto la propria direzione e responsabilità e la collaborazione di altri sia consentita dal contratto o dagli [continua ..]
2.1. Aspetti generali La responsabilità del professionista (rectius del commercialista) origina sostanzialmente dal contratto concluso con il cliente. L’obbligazione assunta con l’accettazione dell’incarico si configura come un’obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato”: il professionista è tenuto a svolgere in modo diligente l’attività richiesta (v. infra), senza peraltro garantire sull’esito finale della prestazione. In altre parole, egli è adempiente, quindi esente da responsabilità, qualora adotti un comportamento idoneo a realizzare l’interesse economico del cliente; è quest’ultimo, infatti, che sopporta il rischio dell’eventuale esito negativo della prestazione, dovendo inoltre corrispondere il compenso indipendentemente dal risultato [3]. Pertanto, l’inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità. Nello specifico, l’inadempimento sarà “assoluto”, qualora la prestazione non sia stata resa, mentre sarà “relativo” quando resa, ma non in maniera esatta o puntuale [4]. Pare, tuttavia, opportuno evidenziare come la giurisprudenza abbia – più volte – derogato al principio della prestazione di mezzi e applicato, anche nelle professioni intellettuali, il criterio della prestazione di risultato. Al fine di assicurare un’appropriata tutela al cliente, al professionista viene chiesto sempre più di rispondere del risultato atteso, soprattutto nel caso in cui quest’ultimo costituisca l’unica ragione del conferimento dell’incarico da parte del cliente (si veda, in particolare, le prestazioni svolte in ambito medico).
2.2.1. La diligenza qualificata La responsabilità contrattuale origina dalla violazione di uno specifico dovere, derivante da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto. Ai sensi dell’art. 1218 c.c. (rubricato “Responsabilità del debitore”), la responsabilità contrattuale sorge in capo al debitore qualora non abbia eseguito la prestazione dovuta o non la abbia eseguita correttamente: l’articolo espressamente prevede che «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». La responsabilità (contrattuale) del commercialista è strettamente correlata al mandato conferitogli dal cliente e, specificatamente, alla diligenza spiegata dallo stesso nell’eseguire la prestazione richiesta. I profili di responsabilità contrattuale del professionista sono disciplinati dall’art. 1176, comma 2, c.c. e dall’art. 2236 c.c. Il primo dispone che «Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata». Si tratta di una diligenza diversa – più specifica – rispetto al criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia di cui al comma 1 del medesimo articolo: è la c.d. diligenza del “debitore qualificato”, caratterizzata dalla «perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare e allo standard professionale della sua categoria», il quale vale a «determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguati per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità» [5]. La diligenza a cui è tenuto il professionista, pertanto, deve essere valutata secondo standard di normalità oggettiva e prescinde – quindi – dalle concrete capacità del soggetto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, delineando i confini di tale diligenza qualificata e stabilendo che [continua ..]
Il dovere di diligenza del commercialista si esplica anche nel c.d. dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, da osservarsi sia nella fase antecedente l’accettazione dell’incarico, nella quale il professionista è chiamato ad informare il cliente dei rischi connessi alla prestazione, sia nel corso del suo espletamento. Il professionista è, in altri termini, tenuto a rappresentare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Nel caso in cui il professionista violi tale obbligo nella fase che precede l’assunzione dell’incarico, si parlerà di responsabilità precontrattuale per lesione dell’altrui libertà negoziale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, stabilendo che il professionista, quale che sia l’oggetto specifico della sua prestazione, «ha l’obbligo di completa informazione del cliente, e dunque ha l’obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse» [10]. Pertanto, al fine di evitare eventuali richieste di risarcimento, il professionista incaricato di una consulenza ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità al cliente; in caso di violazione di tale obbligo e qualora il “consiglio” fornito si sia rivelato erroneo, il commercialista potrà evitare il risarcimento soltanto con la dimostrazione che il danno patito dal cliente è dovuto a fatti a lui non imputabili, in quanto non prevedibili (v. infra). Il dovere di diligenza del professionista imporrebbe – inoltre –, tenuto conto della portata dell’incarico conferitogli, l’obbligo di individuare anche le questioni che esulano dall’ambito della competenza del professionista, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendo elementi e dati nella sua conoscenza, al fine di consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente [11]. Ultimo cenno necessario deve essere fatto ad un ulteriore obbligo, quello di buona fede [continua ..]
La disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale può essere così riassunta: sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 1218 c.c., spetta al debitore inadempiente provare che l’inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile; pertanto, il commercialista – in caso di giudizio – è chiamato a dimostrare di aver agito secondo la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. o in presenza di “problemi tecnici di speciale difficoltà”ex art. 2236 c.c., che gli avrebbero impedito di eseguire adeguatamente la prestazione professionale, dovendo il danneggiato provare solo l’inadempimento e il danno arrecato (ma si veda infra); per quanto concerne il danno risarcibile, questo è limitato ai danni prevedibili al tempo della nascita dell’obbligazione, se la condotta è caratterizzata da colpa del debitore; e anche ai danni non prevedibili, qualora il professionista abbia agito con dolo (art. 1225 c.c.); infine, l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. Nei casi di responsabilità professionale per omissione di condotte che – se tenute – avrebbero potuto produrre un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’applicare, quale criterio probatorio, la c.d. “regola della preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non”, vigente in materia di responsabilità civile (nel processo penale, vige invece la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”). Nell’ambito delle condotte omissive, il risultato della prestazione può essere accertato solo in via presuntiva, sicché l’accertamento della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della prestazione che avrebbe dovuto essere diligentemente eseguita. In altre parole, il giudice, accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno, che probabilmente né è la conseguenza, «può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione [continua ..]
Alla responsabilità contrattuale del professionista, può, a volte, affiancarsi una responsabilità di tipo extracontrattuale (o aquiliana), prevista dall’art. 2043 c.c., rubricato “Risarcimento per fatto illecito”; l’articolo espressamente dispone che «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Tale forma di responsabilità sorge in conseguenza della violazione non già di un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio, bensì di un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con la locuzione latina “neminem laedere”. Si tratta di una responsabilità che, nel caso della colpa professionale, può coesistere con la responsabilità contrattuale e che – quindi – non è esclusa dall’accertamento di quest’ultima. La responsabilità extracontrattuale origina da effetti dannosi determinati dalla condotta omissiva o commissiva del professionista e lesivi di diritti ai quali la legge riconosce tutela. La disciplina applicabile alla responsabilità extracontrattuale può essere così riassunta: sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova, trova applicazione la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., secondo cui spetta al danneggiato provare i fatti alla base dell’illecito e la colpevolezza dell’agente, ossia – nel caso della colpa professionale – la colpevole inosservanza o violazione delle regole tecniche della professione; pare opportuno evidenziare come, nel caso specifico dell’inadempimento del professionista – rispetto quindi al contratto d’opera intellettuale stipulato – la rigida ripartizione dell’onere della prova e la differente disciplina dei due diversi profili di responsabilità (contrattuale e extracontrattuale) tendono a sfumare. Dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova, infatti, la giurisprudenza ormai costante ha affermato un’assimilazione della responsabilità contrattuale a quella aquiliana, essendo il cliente «tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa [continua ..]
La fattispecie di danno tipicamente collegata alla colpa professionale è rappresentata dal “danno patrimoniale”, ossia la lesione di un interesse patrimoniale, suscettibile quindi di essere immediatamente quantificabile economicamente. Esso può derivare tanto da un inadempimento contrattuale quanto da atto illecito. Ai sensi dell’art. 1223 c.c. – rubricato “Risarcimento del danno” –, il danno patrimoniale può configurarsi come: “danno emergente” o “perdita subita”, ossia la perdita economica che il patrimonio del danneggiato ha subito a causa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del professionista. Si tratta di una perdita di utilità già presente nel patrimonio del danneggiato, la cui prova, pertanto, è abbastanza agevole (c.d. prova diretta o storica); “lucro cessante” o “mancato guadagno” patrimoniale, che si sarebbe conseguito qualora l’obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta; il lucro cessante concerne, quindi, una ricchezza non ancora presente nel patrimonio del danneggiato, ma che – in assenza di inadempimento o illecito – ragionevolmente si sarebbe prodotta. La prova può, pertanto, essere fornita attraverso una ricostruzione – secondo un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità – ideale dell’incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito qualora la prestazione fosse stata adeguatamente eseguita (prova indiretta e indiziaria). Naturalmente, ai fini del risarcimento, dovrà essere verificato il nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno, poiché le perdite subite o il mancato guadagno devono rappresentare una «conseguenza immediata e diretta» del fatto.
4.1. Premessa La disciplina codicistica sin qui delineata deve necessariamente essere declinata nelle specifiche attività riconosciute come di competenza del commercialista, al fine di individuare dettagliatamente i diversi profili di responsabilità, nei quali, nell’esercizio della professione, egli può incorrere. A tal proposito, saranno oggetto di specifica trattazione le seguenti attività: (i) assunzione di cariche societarie; (ii) assunzione di incarichi giudiziari; (iii) assunzione dell’incarico di advisor; (iv) consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria. Infine, sarà approfondita la responsabilità del professionista in relazione all’obbligo (o meno) di verifica dei dati forniti dal cliente ai fini fiscali e contabili.
L’attenzione viene posta principalmente all’attività svolta dal commercialista in qualità di sindaco di società di capitali. L’art. 2407 c.c., in tema di responsabilità del collegio sindacale, prevede che «I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica». Il dettato normativo individua due forme di responsabilità imputabili al sindaco: (i) una responsabilità diretta (per fatto esclusivamente proprio), prevista dal comma 1, conseguente alla violazione del dovere di verità nelle attestazioni richieste dalla legge e del dovere di tenere il segreto su fatti e documenti di cui ha avuto conoscenza nell’espletamento dell’incarico, nonché di ogni altro dovere ad egli attribuito dalla legge; (ii) una responsabilità indiretta (per concorso omissivo in fatto illecito altrui) – di cui al comma 2 – e in solido con gli amministratori, connessa all’inosservanza dell’obbligo di vigilanza su questi ultimi, nel caso in cui i fatti e le omissioni dell’organo amministrativo abbiano cagionato un danno ai soci, ai creditori o a terzi. In ordine al secondo profilo della responsabilità (anche detta “culpa in vigilando”), la Suprema Corte ha recentemente pronunciato una circostanziata sentenza [16]. In particolare, gli Ermellini hanno rammentato che, ai fini del giudizio di responsabilità del sindaco, occorre – innanzitutto – l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia: (i) la condotta, consistente nell’inerzia; (ii) l’evento, quale fatto pregiudizievole e antidoveroso altrui; (iii) il nesso causale, mediante il c.d. giudizio controfattuale, allorché l’attivazione avrebbe potuto impedire l’evento, anche con riguardo alla sua protrazione, reiterazione o aggravamento. I doveri di controllo dei membri del collegio sindacale, dettati dagli [continua ..]
L’assunzione di incarichi giudiziari da parte del commercialista può avvenire: (i) nell’ambito delle procedure concorsuali; (ii) in qualità di consulente tecnico del tribunale; (iii) in tutte le altre ipotesi in cui agisce in ambito giudiziale. Di seguito, viene approfondito il ruolo (e la responsabilità) del commercialista nominato curatore fallimentare, estensibile – per analogia – anche ai casi di nomina, sempre nell’ambito delle procedure concorsuali, a commissario giudiziale, commissario liquidatore e liquidatore giudiziale. Il commercialista nominato curatore fallimentare, come espressamente previsto dall’art. 30 l.f., per quanto attiene all’esercizio delle funzioni attribuite, è pubblico ufficiale; egli esercita una funzione pubblica, che – ai sensi dell’art. 31, comma 1, l.f. – si esplica nell’amministrazione del patrimonio fallimentare e nel compimento di tutte le operazioni della procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’interesse – quindi – della giustizia e dei creditori. L’art. 38 l.f. – rubricato “Responsabilità del curatore” – dispone che «Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. [...] Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori». L’inadempimento del curatore si verifica, pertanto, ogni qual volta egli non osservi i doveri specifici stabiliti dalla legge o dal piano di liquidazione approvato; egli risponderà in proprio per eventuali danni cagionati dalla sua gestione. Ipotesi di responsabilità del curatore possono, tra le altre, essere: (i) violazione delle disposizioni del giudice delegato; (ii) compimento di atti svantaggiosi per la procedura; (iii) esperimento di azioni giudiziarie temerarie e inerzia nell’esperimento di liti necessarie; (iv) errori nella redazione dell’inventario; (v) manchevolezze, inesattezze o falsità nella relazione al giudice o nelle relazioni [continua ..]
L’advisor è il professionista incaricato dall’imprenditore di valutare la situazione di crisi dell’impresa, di individuarne le più opportune soluzioni tecniche e di predisporre, in ultimo, lo strumento di regolazione della crisi più consono, sia esso di natura giudiziale o stragiudiziale. Con riferimento alla responsabilità del professionista advisor, i contributi dottrinali e giurisprudenziali sono stati, sino agli anni più recenti, piuttosto scarsi. Né è di aiuto la legislazione: non vi è, infatti, una tipizzazione normativa della figura dell’advisor, né tale attività è oggetto di una qualche professione “regolamentata”. Pertanto, tanto il contenuto della prestazione quanto le caratteristiche della diligenza richiesta non possono che essere rinvenuti, oltre che nella normativa generale dettata dal codice civile – in precedenza descritta – nella leges artis, ossia nell’insieme di regole tecniche che “regolamentano” le modalità di redazione dei piani [20], considerate a tutti gli effetti alla stregua di best practice. Si tratta di standard tecnici, la cui inosservanza da parte del professionista incaricato della redazione del piano di risanamento potrebbe essere fonte di responsabilità, qualora il cliente (rectius l’imprenditore in stato di crisi) o i creditori (v. infra) agiscano per far accertare il nesso di causalità tra la condotta dell’advisor e il fallimento del tentativo di composizione della crisi. Di contro, la prova dell’osservanza di tali standard tecnici non costituisce esonero automatico della responsabilità dell’advisor, potendo il giudice – a seconda del caso concreto – rinvenire altre ipotesi di doveri non adempiuti dal professionista. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha affermato che non può ritenersi adempiente all’obbligazione professionale assunta l’advisor che, nell’assistenza al cliente nella formulazione di una proposta concordataria, violi principi giuridici inderogabili in materia di concordato preventivo [21] o qualora l’uso di una più attenta valutazione della documentazione a sua disposizione avrebbe dovuto portare il professionista a concludere per l’impraticabilità della soluzione [continua ..]
4.5.1. Premessa L’attività di consulenza, assistenza e rappresentanza fiscale rappresenta una delle attività professionali tipiche del commercialista. I profili di responsabilità sono diversi: accanto a quella derivante dall’inottemperanza del dovere di diligenza nell’espletamento dell’incarico, cui consegue l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti del cliente, secondo le regole civilistiche precedentemente descritte, vi è una responsabilità – esclusiva o in concorso – in caso di violazione di norme tributarie e qualora l’attività del professionista abbia determinato o favorito la realizzazione di condotte illecite del cliente; in tal caso, il professionista andrà incontro all’irrogazione di sanzioni amministrative. Le ipotesi di responsabilità del commercialista per violazione del dovere di diligenza nell’ambito della consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria possono essere molteplici e, naturalmente, non possono tutte essere prese in considerazione nel presente lavoro. Ci si limiterà, pertanto, all’approfondimento della responsabilità del commercialista nell’assistenza dinnanzi alle Commissioni Tributarie. Successivamente verranno analizzati i profili di responsabilità del professionista nel caso di illecito tributario.
La responsabilità del commercialista nell’attività di assistenza tecnica davanti alle Commissioni Tributarie si configura, sulla base delle diverse casistiche giurisprudenziali, prevalentemente in condotte omissive, quali la tardiva proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria, l’omessa impugnazione degli atti dell’Amministrazione Finanziaria, l’omessa tempestiva comunicazione della notifica degli atti dell’Amministrazione Finanziaria, con conseguente spirare dei termini per proporre impugnazione. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, inquadrando la responsabilità del commercialista – qualora accertata – nella procurata “perdita di chance”. È stato, di fatti, affermato che «In tema di responsabilità professionale (nella specie di un dottore commercialista), la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria, determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell’an – una volta accertato l’inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l’uso dell’ordinaria diligenza professionale – ma solo, eventualmente, sotto quello del quantum, dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili, ed assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità della situazione giuridica dedotta, ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 c.c.» [26]. La giurisprudenza definisce “chance” non una mera aspettativa di conseguire un determinato bene o vantaggio, ma un’entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, cosicché la sua perdita costituirebbe una lesione all’integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del danneggiante (rectius del commercialista). Il [continua ..]
La responsabilità del professionista legata alla violazione di norme tributarie è sottesa principalmente alle seguenti norme: d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, di «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, di «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, di «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23». Il descritto quadro normativo prevede – per quel che interessa in questa sede – due principi: (i) il principio di “personalizzazione” della sanzione, di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 472/1997, che dispone che «La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione»; (ii) e il principio di “colpevolezza”, sulla base del quale, affinché l’illecito possa essere ritenuto integrato, è necessaria la sussistenza, oltre che dell’elemento oggettivo (violazione della norma), dell’elemento soggettivo, rappresentato dalla “imputabilità”, ossia dalla capacità di intendere e di volere, e dalla “colpevolezza”, ossia dall’aver agito con colpa o dolo. A tal proposito, l’art. 5 del d.lgs. 472/1997 prevede che «Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave», verificandosi “colpa grave” «quando [continua ..]
Di seguito, sono rappresentate alcune pronunce della Suprema Corte sul tema della diligenza del commercialista relativamente ai dati forniti dal cliente ai fini fiscali e contabili. In particolare, la questione affrontata dai giudici di legittimità è se il dovere di diligenza impone al commercialista anche un’attività di verifica della completezza e della correttezza dei dati e dei documenti ricevuti dal cliente per la redazione della dichiarazione dei redditi e per la tenuta della contabilità. Con riferimento all’attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del cliente, la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, si è espressa in senso favorevole al cliente, stabilendo la responsabilità del professionista per non aver verificato l’esattezza delle informazioni fornite dal cliente, condotta che – pertanto – configurerebbe un’ipotesi di violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che è «preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione», a nulla rilevando, al fine di escludere una responsabilità del commercialista, la circostanza che il cliente tenesse in modo disordinato la sua contabilità [32]. In generale, quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a «redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante» [33]. Diverso discorso deve, invece, essere fatto per l’attività svolta dal commercialista in qualità di tenutario delle scritture contabili. Al proposito, è utile richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte [34], che ha escluso la responsabilità del professionista per irregolarità contabili, alle quali ha fatto seguito il ricevimento da parte del cliente di un accertamento di natura fiscale. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che non può essere riconosciuta la richiesta di risarcimento dei danni – avanzata nei confronti del commercialista – per l’avviso di accertamento basato su irregolarità contabili, se il cliente non dimostra di aver consegnato i documenti non correttamente [continua ..]
Una delle ipotesi più frequente di responsabilità penale del commercialista è rappresentata dal concorso nella dichiarazione fraudolenta del cliente e, in generale, nel reato tributario. Affinché possa ritenersi integrato il concorso del professionista sono necessari: (i) la prova del contributo causale di questi alla realizzazione del reato, ossia che l’attività del professionista ha fornito al contribuente un aiuto – morale o materiale – determinante nella realizzazione della condotta criminosa; (ii) l’elemento soggettivo del dolo specifico, ossia che l’apporto prestato dal consulente sia connotato dalla volontà fraudolenta finalizzata all’evasione fiscale altrui (ma si veda infra). La responsabilità a titolo di concorso è esclusa quando il commercialista agisca sulla base dei dati fornitigli dal cliente, che ne garantisce la veridicità senza che sia possibile ravvisare una qualche mendacità degli stessi; è da ritenersi, inoltre, esclusa quando egli abbia prestato una mera consulenza e abbia informato il cliente delle conseguenze, anche penali, delle decisioni assunte dal cliente medesimo. L’art. 2 del d.lgs. 74/2000 disciplina il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, e prevede che «Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria». Ai fini della configurazione del concorso del commercialista nel reato in parola, risulta irrilevante la non materiale presentazione, da parte dello stesso, della dichiarazione fraudolenta. Ai sensi dell’art. 111 c.p., infatti, ad essere oggetto di indagine è l’apporto fornito dal commercialista nella commissione dell’illecito e può integrare la fattispecie del concorso anche la condotta precedente alla effettiva consumazione del reato, qualora di tipo preparatorio, ossia qualora si sia tradotta in istigazione alla presentazione della dichiarazione fraudolenta [35]. Il commercialista può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta agendo, non solo a titolo di dolo specifico, appena descritto, ma anche di dolo eventuale, «ravvisabile [continua ..]
L’esercizio abusivo della professione è un delitto disciplinato dall’art. 348 c.p., che – al comma 1 – dispone che «Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000». La norma è posta a tutela delle c.d. “professioni protette”, per l’esercizio delle quale sono necessari l’abilitazione rilasciata dallo Stato e l’iscrizione a un determinato albo professionale. Dal punto di vista civilistico, l’esercizio abusivo della professione comporta una responsabilità verso il cliente, a cui consegue la nullità assoluta del rapporto tra il professionista e il cliente e l’impossibilità – ai sensi dell’art. 2231 c.c. – per il primo di agire per il pagamento del proprio compenso. Il reato in parola ha natura istantanea, in quanto è sufficiente – ai fini della sua integrazione – la commissione anche di un solo atto “riservato in via esclusiva” ad una precisa professione, ancorché compiuto in modo occasionale o a titolo gratuito. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità propende ormai per un’interpretazione estensiva del disposto di cui all’art. 348 c.p., ritenendo integrato il reato di esercizio abusivo della professione anche in presenza del compimento senza titolo di atti non attribuiti in via esclusiva, ma qualificati – nelle regolamentazioni dei singoli albi professionali – come di specifica o particolare competenza di una data professione (cd. “atti caratteristici o strumentalmente connessi” agli atti tipici), qualora posti in essere «con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato», ossia con modalità tali da creare le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta in maniera lecita, con evidente realizzazione dei presupposti dell’esercizio abusivo, sanzionato dalla norma penale [37]. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato come il reato di cui all’art. 348 c.p. sia posto primariamente a salvaguardia delle [continua ..]